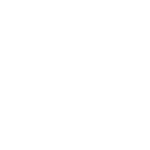anche la famiglia, secondo questa definizione, è un'azienda. L'azienda, normalmente, produce beni o servizi e soddisfa queste esigenze tramite una relazione di scambio di utilità tra i soggetti, mentre l'azienda sociale lo fa attraverso una relazione di reciprocità ed è questo il nostro grande punto di forza. Qui siamo in un ambito particolare che, pedagogicamente, è molto interessante: la nostra forza - che è anche quella del volontariato - sta nel fatto che alla base c'è una relazione di reciprocità che non è solo una bella parola, ma significa che l'erogatore di una prestazione si aspetta che, prima o poi, il ricevente si sdebiti. Questa relazione di reciprocità è importantissima perché immette nel tessuto locale quella rete di protezione che le tensioni troppo forti dei processi di globalizzazione stanno smagliando. Questi, secondo me, sono dei temi, delle provocazioni pedagogiche e pastorali che lascio aperte, sperando che le sviluppiate nei lavori di oggi pomeriggio. Per me sono state cose affascinanti che mi hanno fatto percorrere delle strade, magari un po' tortuose, ma sappiamo che il Signore non le fa sempre diritte, altrimenti sarebbe troppo facile seguirle. Michele Santini Vicepresidente nazionale CSI (Centro Sportivo Italiano)
Nell'immaginario collettivo e nella società di oggi lo sport, quello praticato da milioni di persone, è tempo perso. Perché? E tempo perso per le parrocchie, perché rimane il momento ricreativo, cioè la cosa meno seria tra le cose serie che fa la parrocchia per cui è uno spazio al quale si dà poco significato. Lo è nella scuola, lo è stato e lo è tuttora perché, nonostante qualche novità, l'ora di educazione fisica è l'ora del non far niente, dove gli studenti vengono lasciati a se stessi. Lo è nella società civile, perché manca una legge sullo sport. Ogni volta che questa legge sta per andare in porto, salta il governo, per cui l'Italia è l'unica nazione in Europa a non avere una legge sullo sport. Tutto questo significa che si pensa allo sport come qualcosa di marginale, di esterno alla persona, con poco significato per la vita. Eppure sappiamo che venticinque italiani su cento, circa 13 milioni, praticano regolarmente un'attività sportiva, mentre un'altra buona percentuale lo pratica saltuariamente. Negli ultimi rapporti IARD sulla pratica sportiva giovanile, si nota che i giovani abbandonano lo sport professionale, quello visto in una funzione di un risultato tecnico, mentre partecipano di più a quello vissuto dentro le associazioni che promuovono lo sport e altre iniziative. Ciò significa che i giovani, in questo momento, anche attraverso lo sport, il tempo libero, chiedono proposte forti, convincenti e coinvolgenti, e si esprimono soprattutto attraverso linguaggi emotivi prendendo le distanze dallo sport che è soltanto agonismo esasperato e preferendo quello che è inserito dentro ad altri contesti di vita. Sostanzialmente lo sport, prima di essere un'esperienza fisica, un risultato tecnico, uno spettacolo, un mercato, è un'esperienza che deve mettere al centro l'uomo, cioè incontrare l'uomo, la persona, il suo sapere, la sua educazione religiosa. Lo sport che mette al centro la persona è un valore. Ecco perché sempre di più in Italia ci sono associazioni di promozione sportiva, che hanno sostanzialmente raddoppiato i loro iscritti, mentre alcune federazioni li hanno visti calare vorticosamente. Questo sta a significare che lo sport viene vissuto sempre di più come valore capace di aggregare le persone, di impegnare il loro tempo libero in un percorso di crescita. Lo sport che mette al centro la persona, è lo sport che sceglie gli ultimi, che non è schizzinoso, non sceglie solo i più bravi, quelli che sanno giocare, che riescono ad ottenere risultati apprezzabili, ma sceglie i portatori di handicap, il popolo dei bar, del muretto, della piazza, della strada, i terzo mondiali. Ecco che lo sport diventa di valore e acquista un significato per le persone che lo praticano. Lo sport diventa strumento educativo, se si mette a servizio dell'uomo per riscattarlo e per promuoverlo, senza entrare nella logica esasperata del mercato e del commercio, ma innescando una serie di processi che aiutino ad umanizzare le persone creando nuove relazioni e aprendo alla solidarietà. In questa società distratta, dove le persone stanno insieme ma non si incontrano, lo sport può diventare un'occasione per far incontrare la gente, rimettere al centro il senso della solidarietà, creare reti di rapporti. E mentre oggi tutto viene monetizzato, tutto ha un costo, tutto risponde ad un guadagno, dai sentimenti, alla vita sociale, al tempo libero, lo sport deve recuperare la sua ludicità, il suo aspetto di gioco, di festa, di incontro, dove valgono alcuni valori: la fatica dello stare insieme, la pazienza e la costanza dell'allenamento. Lo sport, oltre alla dimensione sportiva, deve recuperare la sua dimensione associativa, la capacità di condividere risorse e valori diversi che sono risorse e valori umani. Deve recuperare anche la dimensione sociale che consiste nel porsi a fianco dell'uomo, a fianco del giovane per toglierlo dallo sua situazione di marginalità, e riuscire a fargli condividere, con tutti gli altri, momenti e spazi di vita sportiva e di festa. Lo sport deve recuperare anche la sua dimensione pastorale nel mondo dei giovani, nel senso che la stessa comunità parrocchiale deve ridare il giusto valore allo sport come momento importante delle sue attività pastorali. Lo sport deve altresì riscoprire la sua dimensione missionaria come apertura all'altro, per creare quella rete di accoglienza e condivisione di un progetto sportivo che faccia stare insieme per andare oltre lo sport. Tutti i soggetti della nostra società devono poter considerare lo sport come uno strumento che può collaborare a ridare vita alla società stessa in quanto strumento di festa, di condivisione, di partecipazione, di umanizzazione. Lo sport può riuscire, così, a mettere insieme le diversità come ricchezza e non come divisione, e aiutare a crescere insieme; ma perché tutto questo avvenga c'è bisogno di un patto di collaborazione, di una rete di rapporti, con gli altri mondi vitali della società civile.
Francesco Baldoni mondo della cooperazione sociale/Acli
Il terzo settore, attraverso la cooperazione sociale, deve dare un grosso apporto per risolvere in modo coordinato e continuativo una serie di problemi di natura sociale, ambientale e legati alla dimensione della salute. Tutto questo è possibile con la legge sulla cooperazione sociale, uno strumento legislativo di una quindicina di anni fa, che permette alle aziende cooperative di funzionare in modo un po' diverso. Questa sensazione nuova attorno a questi temi è sia ecclesiale - la si percepisce in alcuni documenti fondamentali -, sia laica poiché il sistema ha bisogno di qualcosa d'altro. Il mio discorso vuol partire da una sensibilità sia ecclesiale che laica attorno a questo settore no-profit che non vuol dire non profitto, ma "not for profit", non per profitto, cioè il profitto dev'essere obbligatoriamente reinvestito. Specifico subito con n esempio: c'è una riga e si ha in mano un sasso; la riga identifica il pareggio tra costi e ricavi. Nell'azienda "for profit" il gioco è tirare il sasso più lontano possibile dalla riga e quello è il profitto, e lì dentro c'è la remunerazione del rischio dell'imprenditore, la remunerazione del capitale. Nell'azienda "not for profit" il gioco è superare la riga, rimanendo il più possibile vicina ad essa: è un gioco difficile, ma bisogna superarlo. Il rapporto Delors indicava l'azienda "no profit" quale veicolo trainante, anche dal punto di vista occupazionale, negli anni '90. Questo sarebbe stato inconcepibile 30 anni fa, perché il nostro sistema ha considerato, finora, come valori portanti dell'azione economica e del lavoro, il paradigma della crescita illimitata. Questo paradigma si basava sulla fiducia illimitata nel fatto che il benessere e la produzione e i consumi continuavano a crescere senza gravi danni. Anche la presenza del sindacato, delle associazioni di categoria degli imprenditori ha prodotto una forte concentrazione al momento della creazione della ricchezza e una divisione dialettica nel momento della ridistribuzione. Questo meccanismo darà luogo nei paesi sviluppati ad un sistema sanitario nazionale mentre nelle socialdemocrazie del Nord d'Europa a dei sistemi di protezione sociale "dalla culla alla tomba". Questo paradigma, ultimamente, incomincia ad incrinarsi, a rallentare, a segnare il passo perché ci troviamo di fronte ad una globalizzazione che spinge le aziende a considerare sempre di più gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi. In questo quadro incominciano ad essere presenti delle esperienze nuove come la forma di imprenditorialità nella cooperazione sociale. Pensate che cosa può rappresentare la certificazione di qualità sia del prodotto che del processo per le aziende "for profit"; non è soltanto un plus competitivo per vendere meglio, è il consumatore che comincia a pretendere alcune garanzie: "Voglio i l prodotto biodegradabile, il prodotto sicuro". Questa serie di sicurezze che la certificazione di qualità implica premia i prodotti con la scelta da parte dei consumatori. Pensate ancora ai bilanci sociali: ci sono aziende che ci tengono a far sapere, in modo trasparente e coerente, quanto spendono a favore della formazione interna, degli investimenti per diminuire l'impatto ambientale, per la sicurezza sui luoghi del lavoro, per i benefici verso i familiari dei dipendenti... Qual è il ruolo della cooperazione sociale in questo ambito? Ho accennato prima alle novità e alle emergenze connesse con la globalizzazione che implica anche dei rischi e una tensione verso il basso, verso forme di povertà. La cooperazione sociale offre delle risposte, perché è nel mercato, quindi sfrutta le positività innate che il mercato ha: il fatto che il servizio viene offerto all'utente al minor prezzo possibile confacentemente con la qualità accettabile; il fatto che aiuta la pubblica amministrazione nell'espletamento di alcune risposte ai bisogni fondamentali di sicurezza; il fatto che crea posti di lavoro nel campo dei servizi alla persona. Faccio un inciso per chi non conosce bene la cooperazione sociale. In Italia esistono due tipi di cooperative sociali - in Europa abbiamo la normativa più avanzata in questo campo -, le cooperative di tipo "A", sono quelle che regolano i servizi socio-assistenziali: assistenza domiciliare agli anziani, gestione di comunità per tossicodipendenti, per malati psichiatrici, servizi anche educativi quali scuole o asili nido. Poi ci sono le cooperative di tipo "B", dove invece c'è un normalissimo processo di tipo artigianale, manuale, svolto dai cosiddetti soci svantaggiati, quindi ex tossicodipendenti, ex detenuti, portatori di handicap che vengono inseriti in un ciclo lavorativo. Vorrei dirvi ora il perché ho fatto la scelta di lavorare in un'azienda sociale. Ho una Laurea in Economia aziendale conseguita alla Cà Foscari a Venezia, faccio parte di un'associazione cristiana che ha a che fare con le problematiche del mondo del lavoro. Ho fatto esperienze di volontariato con l'handicap e alla fine del mio percorso formativo mi sono trovato alle prese con uno zio, un grosso produttore in metallurgia leggera, che mi ha detto: "Bello di zio vieni qui, che dobbiamo prendere il direttore commerciale nuovo, vieni, vieni". Nel frattempo, mentre preparavo la tesi, ho fatto l'operatore in un Istituto e il servizio civile in un opera di don Guanella ed ho cominciato ad avere una certa promiscuità quotidiana con la dimensione sociale del lavoro. Terminato il servizio civile sono stato in azienda. Nonostante tutto, sono stato due mesi, perché al direttore commerciale ho fatto presente che ero più propenso a svolgere altre mansioni piuttosto che il controllo di gestione e un po' perché non mi è stato consentito di fare impresa in maniera sociale, per cercare di continuare quello che avevo cominciato a fare. Lasciata l'azienda dello zio, sono ritornato a Trento ed ho frequentato un Master sulle aziende no-profit per sei mesi e, barcamenandomi tra una centrale cooperativa e un altro lavoretto che avevo, sono riuscito, in due anni, a costruire la mia professionalità fino a diventare il responsabile qualità di una cooperativa. Più che azienda cooperativa, la definisco una grande impresa illuminata perché siamo in 700, quindi è un po' difficile rimanere ancorati alla spinta cooperativa che viene dalla dimensione piccola. Quello che mi interessa comunicare a voi è che quelle scelte che ho fatto, sono state delle scelte fondamentalmente motivate e di auto-imprenditorialità, ma mi hanno anche dato la possibilità di un lavoro che mi affascina profondamente. Vorrei semplicemente dirvi quali sono stati i motivi portanti e quali potrebbero essere i cammini formativi per avvicinarsi a questo settore, o per far avvicinare più agevolmente possibile chi volesse fare delle scelte analoghe. In primo luogo la percezione molto netta che, con tutte le distorsioni di questo mondo perché tutto è imperfetto, l'impresa cooperativa può offrire degli spazi di partecipazione basati sul merito ma anche sulla dimensione della progettualità e contemporaneamente anche del sogno. Anche le aziende vengono spostate dai miraggi di espansione quindi, il mio sogno era quello di coniugare bisogni sociali, di protezione sociale, di efficienza, in una società che garantisse un posto di lavoro con una retribuzione equa. Questa aspirazione è diffusa più di quanto si pensi nei giovani. Solitamente chi viene a lavorare nella cooperativa sociale non è lo "sfigatone" che non trova posto dalle altre parti, anche perché quello, senza motivazioni profonde dura pochi mesi. Quindi io suggerirei di lavorare molto sulle motivazioni, sul bisogno di giustizia che è presente più di quello che si pensa. Lavorando in quella centrale cooperativa, ho trovato degli imprenditori sociali di uno zelo nettamente superiore al buon amministratore di una normalissima azienda "for profit". Vorrei anche ricordare che la cooperazione sociale è quella che opera con una tensione costante alla qualità. Paradossalmente la qualità concepita in senso aziendale è il "no-profit" che la insegna al "for profit", perché nel "no-profit" è impensabile una cooperativa sociale che non ha uno spirito collaborativo, che le informazioni non siano diffuse in tutta l'azienda. Il discorso di lavorare in una équipe, nella fluidità del pensiero, nella condivisione degli obiettivi è già all'interno dell'azienda no-profit. Vorrei concludere con una nota che dal punto di vista pedagogico potrebbe interessarvi. La cooperazione sociale non è la più brava della classe, è una azienda diversa dalle altre, un'impresa sociale che offre grosse possibilità, definita da Zappa, fondatore dell'aziendalismo e della moderna contabilità, "un insieme di persone e risorse messe assieme in modo duraturo per poter rispondere ai bisogni umani". Si noti co me