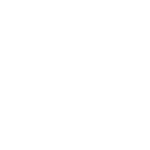compiti di docenza sia per le mansioni da rimpiazzare all'interno dei luoghi di produzione. Anche nel settore dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alcuni servizi alla persona possono essere la fonte di nuovi tipi di lavoro che del resto, in parte, le associazioni già forniscono, come ad esempio con la rete dei patronati. In questa prospettiva, riprendendo alcuni cenni fatti sopra, si collocano anche la crescita e lo sviluppo dell'economia civile o del terzo settore, che da noi ha ancora percentuali basse (siamo tra l'1 e il 2% mentre potremmo arrivare fino al 5-6% come in altri Paesi dell'Europa o negli Stati Uniti). Come non vedere però che per far crescere il terzo settore o l'economia civile bisogna dotarsi di una cultura del lavoro più ricca, più adeguata alla lettura e alla soddisfazione di una gamma più ampia di bisogni ed essere capaci di inquadrare il lavoro sempre più nella prospettiva della qualità della vita piuttosto che in quella dell'accrescimento quantitativo? Perseguimento della qualità della vita e di un'antropologia complessiva, al cui interno collocare il lavoro, mi pare facciano un tutt'uno. Quelle che vi ho offerto sono piste di riflessione che, per quanto solo abbozzate, spero possano essere utili per la vostra ricerca e per il vostro operare.1. Premessa Ho pensato di segnare quanto dirò con una triplice demarcazione riflessiva. Il primo punto sviluppa una riflessione sulla percezione e sul vissuto del lavoro. Non si tratta di una riflessione in termini psicologici e nemmeno sociologici, ma in termini antropologici e storici. Il secondo momento può essere così sintetizzato: come si può collocare il lavoro in una prospettiva antropologica più adeguata e soddisfacente; che cosa si può dire, in senso propositivo, riguardo ad una cultura del lavoro che affronti la situazione attuale ma non si appiattisca su di essa. Il terzo punto della riflessione potrebbe essere questo: quali ricadute pratiche e operative si legano ad un ripensamento del lavoro, soprattutto in ordine ai problemi della disoccupazione o meglio, in termini positivi, in ordine ad una diversa condivisione del lavoro. Questi temi li abbiamo già affrontati, in una certa misura, nel Convegno nazionale organizzato dalla Pastorale del lavoro nel '98 a Roma, per cui oggi penso di proporvi, più che dei contenuti elaborati analiticamente, una traccia che si annoda intorno ad una problematica di natura culturale-antropologica, poichè il problema del lavoro è innanzitutto problema attinente a ciò che è l'umano. Quanto al metodo, cercherò di considerare le cose nel loro stato fattuale e, insieme, di dare una prospettiva diversa rispetto alla situazione attuale. 2. Il vissuto del lavoro oggi Voler definire, riguardo al lavoro, un atteggiamento fondamentale in modo univoco può sembrare presuntuoso e anche non realistico; ci sono effettivamente diverse culture del lavoro che è difficile portare ad unità. Per rendere l'idea di ciò che può essere il vissuto del lavoro oggi mi permetto di ricordare come noi siamo gli eredi di una visione utopica del lavoro - quella che ci è stata tramandata dal XIX secolo - nella quale il lavoro non è soltanto una parte importante dell'umano, ma diventa la parte più rilevante fino a diventare addirittura il tutto. L'uomo è essenzialmente lavoro, così come lavoro è anche la storia, la storia già fatta e soprattutto la storia da fare. I pensatori che sono gli interpreti di questa visione vanno da Locke fino a Marx, nel quale il lavoro, oltre che essere elemento essenziale dell'umano, ne costituisce la totalità ed è il motore determinante del processo storico. Questa stagione utopica del lavoro è certamente positiva perché nella cultura dell'Ottocento il lavoro entra a definire, a pieno titolo, l'umano; ma presenta anche un limite che è connesso alla stessa utopia del lavoro, perché questa si trasforma, per così dire, in una sorta di ipertrofia lavoristica che comporta l'appiattimento dell'umano sul lavoro e quindi sul registro della produzione. Qui ci si imbatte anche in una visione della soggettività moderna che ritiene che tutto sia a disposizione del soggetto umano, con conseguenze notevoli, per esempio, riguardo alla natura, al rispetto dell'ambiente, alla manipolazione delle cose in generale. Siamo di fronte ad un soggetto che attribuisce a sé una capacità illimitata di manipolazione. Potremmo continuare nella storia delle idee, ma intendo offrirvi solo una traccia che potrebbe essere completata con contenuti ulteriori. Questa visione ipertrofica è stata messa a dura prova dalla realtà dell'organizzazione del lavoro. Qui emerge l'altro lato da tenere sott'occhio: oltre alla storia delle idee, c'è una storia del lavoro come fatto, del lavoro come vicenda fattuale. Nella sua vicenda fattuale e nei modi in cui è stato organizzato, il lavoro è andato appunto perdendo sempre di più il suo alone utopico. Questo lo si constata, in particolare, nell'ambito della organizzazione scientifica del lavoro che decolla agli inizi del XX secolo e poi si condensa nella impostazione ford-tayloristica del processo produttivo. Sappiamo bene che l'organizzazione ford-tayloristica del lavoro comporta la parcellizzazione delle operazioni lavorative, quindi l'individuazione di mansioni il più possibile semplici, per cui il soggetto è addetto a compiti parcellizzati e semplificati con l'idea di esonerarlo persino dalla fatica del pensare. Ford e Taylor, da questo punto di vista, si ritenevano dei benefattori dell'umanità, perché appunto sollevavano il lavoro dalla fatica mentale. Del resto ricorderete che anche Gramsci, quando parla del fordismo, afferma che, tutto sommato, l'organizzazione scientifica del lavoro permette alla mente di tenersi libera e disponibile per l'impegno politico. Altre sono state le preoccupazioni di quanti, nel XX secolo, hanno criticato l'impostazione ford-tayloristica del lavoro fino a parlare di degradazione del lavoro, in quanto esso perde di autonomia, di creatività, di globalità e si riduce ad esecuzione di operazioni standardizzate. Alla stagione della organizzazione ford-tayloristica del lavoro si oppone la stagione più recente dell'impostazione del lavoro secondo i dettami della qualità totale, che cerca di rispondere ai limiti della impostazione precedente mettendo insieme ideazione ed esecuzione, e quindi collegando al processo produttivo le competenze specifiche a tutti i livelli, anche ai livelli più bassi della scala delle mansioni (tanto è vero che la qualità totale ha fatto sorgere problemi di scavalcamento per i quadri medi della produzione). E chiaro che qui non possiamo pronunciarci sugli esiti e sulle applicazioni effettive della qualità totale. Molti ritengono, fra questi per esempio Bruno Trentin, che l'organizzazione del lavoro oggi sia ancora, di fatto, largamente di tipo ford-tayloristico e che la qualità totale non abbia preso molto piede. Indubbiamente, però, dobbiamo tenere conto del carattere innovativo della qualità totale rispetto all'impostazione ford-tayloristica, in quanto intende ricomporre i momenti della produzione che l'impostazione precedente separava. Facendo un bilancio d'insieme, nel panorama attuale non è comunque contestabile, a mio avviso, quello che si può chiamare l'indebolimento della visione utopica del lavoro; siamo entrati in una fase più prosaica in cui il lavoro non viene più circondato dell'alone quasi messianico che gli era stato attribuito in precedenza. Il lavoro diventa un momento non eludibile sia della vicenda individuale sia di quella collettiva, ma non viene più percepito come il momento risolutivo. Non intendo negare che il lavoro abbia oggi una rilevanza e che sia uno dei 'fuochi' importanti dell'esistenza, ma porlo al centro di tutto mi pare sia stato anche il vizio di ingenuità o di retorica di un certo modo di fare pastorale del lavoro. Questo lo dico come provocazione per una riflessione oltre gli eccessi del lavorismo. In altre parole, siamo passati dalla poesia alla prosa per quanto riguarda la visione del lavoro; si è verificata una sorta di relativizzazione culturale del lavoro; i toni si sono smorzati rispetto alla sua stagione utopica. Questo però non significa che il lavoro, nella condizione di vita effettiva, sia diminuito. Anzi il lavoro si è addirittura esteso quantitativamente e si è intensificato venendo a riempire sempre di più il tempo di vita dei soggetti, per cui l'indebolimento della visione utopica del lavoro è andato di pari passo con la sua dilatazione di fatto. Tornando sul versante della considerazione teorica sul lavoro, mi sembra che su tale piano si siano profilate, con nettezza, due piste di riflessione critica alla cui rispettiva peculiarità è bene fare attenzione. La prima è quella che può essere riconosciuta come critica dell'alienazione che avviene all'interno dei processi di lavoro. Essa è certamente tributaria della visione utopica del lavoro. Quest'ultima è stata infatti feconda nel fornire i concetti per una critica permanente dei processi di alienazione nel lavoro, alienazione che in sostanza si verifica quando non si controllano più i fini della produzione e il lavorare si riduce ad un avere a che fare soltanto con i mezzi. Più radicalmente, l'alienazione nel lavoro viene ravvisata nel fatto che il lavoratore diventa semplicemente mezzo della produzione e quindi colui che dovrebbe essere il fine del produrre, con un vero e proprio rovesciamento di senso, diventa strumento del produrre, cioè, nell'apparato produttivo organizzato scientificamente, strumento delle macchine o della tecnologia e, in definitiva, la ruota di un ingranaggio impersonale. La seconda pista di riflessione si può chiamare critica dell'alienazione da lavoro ed è invece tributaria di una visione che lo relativizza. Se il lavoro viene tolto dal suo alone di assolutezza, ci si rende conto che vivere in modo esclusivo nel lavoro, lasciandosi assorbire totalmente da esso, è un altro tipo di alienazione. L'umano, infatti, non può ridursi alla semplice dimensione lavorativa e il lavoro, anche se trasformato e qualificato, resta pur sempre un momento dell'esplicazione complessiva dell'umano, senza poter pretendere di esaurirlo. Nella misura in cui l'uomo viene assorbito integralmente dal lavoro patisce l'alienazione da lavoro, anche se dovesse svolgere un lavoro non ridotto a semplice strumentalità. A dire il vero, nella mentalità dominante a livello spicciolo ciò che oggi prevale è un ibrido consistente, per un verso, nell'accettazione della strumentalità del lavoro e, per altro verso, nella disponibilità a farsene assorbire. Il cliché più diffuso, riguardo al lavoro, è infatti quello in base al quale esso viene concepito come strumentale ad una sfera che è diventata più importante del lavoro stesso, la sfera dei consumi nell'ambito del tempo libero. La laicizzazione del lavoro, al di là dell'utopia ottocentesca, porta cioè molto spesso ad assumerlo come attività strumentale in vista delle possibilità che esso offre nella sfera dei consumi, spostando il baricentro esistenziale dal lavoro alle gratificazioni offerte dai consumi, dal lavoro ad un tempo libero inteso come tempo del consumare. Ma proprio un tale non conferimento di un senso intrinseco al lavoro, da non confondere con una giusta relativizzazione, comporta poi l'accettazione di qualsiasi lavoro, purché esso sia fonte di guadagni utili al consumo del tempo libero. Ne consegue non un maturo superamento dell'assolutizzazione del lavoro, ma piuttosto una forte demotivazione riguardo alla sua sostanza intrinseca. Il lavoro, non più apprezzato nella sua relativa positività, decade a momento da subire o scotto da pagare soltanto in vista di vantaggi che sono completamente al di là della sfera del lavoro. Questi atteggiamenti di demotivazione, che non sono accompagnati da frustrazione ma sono per lo più assunti e vissuti lucidamente, mi sembrano diffusi in modo particolare presso i giovani. Questi sono molto disincantati anche perché non trovano facilmente un lavoro davvero gratificante, che sia, per esempio, in linea con il loro curriculum scolastico e, quindi, finiscono con l'adattarsi ai molteplici lavori occasionali, senza pretese eccessive di qualificazione, perché ripongono il luogo di soddisfazione del loro stile di vita in un'altra sfera, quella appunto del tempo libero e dei consumi. Certamente tutto ciò, per dirla molto schematicamente, non è accettabile. A mio avviso occorre guardarsi sia dall'ipertrofia del lavoro, perché mortifica altri aspetti importanti dell'umano, sia dallo svuotamento delle motivazioni al lavoro, a sua volta mortificante. Come è possibile rimotivare il lavoro? Dare senso alla persona nel lavoro? Questo è un compito importante e urgente. Una demotivazione rispetto al lavoro rischia infatti di non far cogliere le nuove opportunità per una sua riqualificazione, che sono offerte dalle stesse innovazioni organizzative e tecnologiche più recenti. Pur tra ambiguità e ottimismi di maniera, è in corso un arricchimento tecnologico del lavoro che esigerebbe un coinvolgimento personale più sostanzioso, una capacità di progettazione di sé più ricca. Senza di ciò vengono a mancare le energie di partecipazione e di innovazione non soltanto produttiva, ma soprattutto strategico-politica. Il controllo dei modi e dei risultati del lavoro, pur contestualizzato nei suoi limiti, è tra l'altro uno dei pilastri irrinunciabili di quella democrazia economica che fa parte del nostro bagaglio concettuale. La democrazia economica esige senza dubbio una maggiore capacità di controllo e di orientamento dei fini e dei modi della produzione. Ma come è possibile controllare fini e modi della produzione, grazie anche all'evoluzione delle tecnologie, senza motivazioni adeguate al compito lavorativo? Se il lavoro viene abbandonato ad una visione puramente strumentale, sarà scarsa l'applicazione alle potenzialità strategico-politiche che esso può offrire. Si tratta, quindi, di rimotivare chi lavora all'importanza del lavoro, un'importanza che non è soltanto di tipo individuale, ma anche di tipo sociale e civile. Si profilano allora esigenze di promozione dell'identità del soggetto che lavora, in una situazione nella quale, insieme alle opportunità, ci sono fattori di discontinuità e di contrasto tali da negare o sopravanzare gli aspetti positivi, con effetti di spiazzamento e di frammentazione. In una fase nella quale, nella vita di ciascuno, i lavori si susseguono in modo non ordinato e nemmeno coordinato, è difficile mantenere un'identità del soggetto; esiste il rischio grave della dispersione di una personalità che si adegua in modo passivo a quelle che sono le connotazioni di un lavoro che sul piano oggettivo ha assunto i tratti della diversificazione incessante. In una situazione del genere diventa fondamentale l'opera dell'accompagnamento. Anche alla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, a Napoli, si è parlato molto dell'istanza dell'accompagnamento del soggetto che lavora nella serie dei percorsi che egli deve compiere. 3. Il lavoro in una prospettiva antropologica più adeguata e soddisfacente Ma con quale visione della vita e della persona è possibile accompagnare il soggetto che lavora lungo i percorsi accidentati della sua esistenza lavorativa? A questo proposito penso sia necessario fare un salto di qualità nell'investimento che si fa nei confronti del lavoro, passando da un'assunzione del lavoro nella sua esclusività all'assunzione delle esigenze, dei bisogni e delle prospettive della persona che lavora. Di conseguenza è necessario elaborare una cultura che punti innanzitutto sulla persona, nell'insieme delle sue componenti, all'interno delle quali metta a tema l'importanza del lavoro. Per fare questo bisogna avere però una visione complessiva della persona, che non si limiti al semplice lavoro. Riprendendo schematicamente cose che ho già scritto altrove (Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà, Vita e Pensiero, Milano 1999 prima ristampa), sostengo che pensare la persona nella sua complessità, o nella sua globalità, vuol dire vederla come capace di lavorare, di agire e di essere. Un'antropologia complessiva, infatti, è quella che assume non soltanto il lavorare ma anche l'agire e l'essere. L'essere è l'insieme del reale e del possibile, è la sfera del gratuito, del non producibile. L'essere suscita stupore, meraviglia e quindi offre all'umano la massima ampiezza delle prospettive che esso può coltivare. Qui il discorso si apre sul versante religioso e teologico che non sta a me completare. L'essenziale è che il riferimento all'essere esprima una dimensione che non può essere risolta nel produrre. Il riferimento all'essere è la critica di ogni pretesa di manipolazione assoluta della realtà: l'essere ci limita e, quindi, ci conduce ad osservare una misura. L'agire è portare a manifestazione l'essere che è in noi e negli altri; l'agire è innanzitutto un più di essere, prima ancora che un più di avere. Nell'agire costruiamo ciò che noi siamo e ciò che gli altri sono nella loro autonomia ma grazie anche al rapporto che intrecciamo con loro. Il lavorare è un porre capo a delle oggettivazioni, per cui nel lavorare la logica dell'essere e dell'agire, in una certa misura, si rovescia mettendo il nostro essere a disposizione di un avere, non perché l'avere e l'essere siano separabili, ma perché il compito del lavorare esige di renderci strumento per la produzione di oggetti. Il lavoro comporta umiltà, capacità di mettere l'essere al servizio dell'avere e questo non è per niente scandaloso né negativo, ma non deve essere assolutizzato, altrimenti si cade nell'ideologia del produttivismo o del lavorismo. Da questa visione globale della persona e dall'inserimento in essa del lavoro scaturisce un'indicazione di contenimento del lavoro "a rischio di inquinamento antropologico", cioè di un tipo di lavoro che sia di impedimento all'agire e all'essere, all'azione e alla contemplazione, alla realizzazione nel rapporto con gli altri - per esempio, a livello degli impegni politici intesi in senso lato - all'attività di formazione della personalità, alla maturazione del discernimento del senso, del vero, del bello, del buono. In secondo luogo, anche se è una successione logica e non cronologica, il riferimento del lavoro ad un'antropologia aperta alla globalità delle componenti umane, può portare ad un lavoro inteso in modo più ricco, tale cioè da incorporare in sé elementi di azione e di contemplazione. Tutto ciò si traduce nel pensare il lavoro secondo una triplice valenza: secondo autenticità, in quanto il lavoro realizza effettivamente la persona che lo compie; secondo efficacia, in quanto il lavoro pone capo a oggetti affidabili e ben fatti; e secondo spiritualità, che è fondamento della capacità di condividere il lavoro con gli altri e quindi di socializzarlo. Da queste riflessioni scaturisce l'investimento etico riguardo al lavoro: come impegno a conferire autenticità all'attività lavorativa (etica del lavoro), ad acquisire le virtù generiche e le abilità specifiche del compito lavorativo determinato (etica nel lavoro), e a rendere il lavoro bene disponibile per tutti (etica per il lavoro). 4. Risvolti politici ed economici Il discorso di ampliamento antropologico della considerazione del lavoro comporta poi risvolti politici ed economici. A livello politico si tratta di assumere il lavoro come bene di cittadinanza, partecipabile da tutti, e quindi di contrastare ogni indulgenza a quella che è stata chiamata la società duale, in cui vigerebbe la dicotomia tra gli inclusi e gli esclusi dal lavoro. Questa è una sfida importantissima dal momento che il lavoro, oltre che essere un diritto in sé, è la via di accesso anche agli altri diritti della cittadinanza. Non siamo certo nell'ambito delle verità di fede, però si può dire che nell'evoluzione storica il lavoro è indubbiamente diventato la via dell'accesso all'insieme dei diritti e che è bene continui ad esserlo. Il lavoro ha assunto una funzione di ordinatore sociale la cui cancellazione pura e semplice è da scongiurare. Questo non significa che bisogna accanirsi nella sottolineatura unilaterale del lavoro; anzi, più si ha una visione di condivisione del lavoro, legata alle coordinate dell'agire e dell'essere, meglio si può tradurre in pratica una politica del lavoro come diritto per tutti. Sono convinto che l'accanimento lavoristico abbia portato anche ad un'etica individualistica, ad un accaparramento del lavoro come bene per sé ad esclusione degli altri, mentre l'inserimento del lavoro in un'antropologia più ricca può propiziare un vissuto di partecipazione culturale che si traduce anche in una politica di migliore distribuzione del lavoro. E' possibile situare in tale orizzonte l'importanza delle politiche attive del lavoro, in quanto politiche di creazione del lavoro in vista della soddisfazione dei bisogni di cittadinanza. Qui si apre pure il capitolo della valorizzazione delle iniziative della società civile, quindi di una politica del lavoro e per il lavoro che faccia posto a ciò che si organizza nella sfera della società civile con risorse proprie che hanno però bisogno di essere incentivate e di essere stimolate da una politica adeguata. Qui si inserisce altresì il capitolo della formazione o della politica dei diritti formativi, che debbono essere soddisfatti perché si arrivi ad una giusta flessibilità del lavoro, non ridotta a pura precarietà, ma tale da consentire di stare nei percorsi lavorativi con la capacità di controllarne l'evoluzione e l'esito grazie appunto all'acquisizione di competenze che possono essere spese in una molteplicità di lavori. Una flessibilità, quindi, che non diventa frustrante, ma di arricchimento per il soggetto che lavora. Per quanto riguarda i risvolti economici, dalla condivisione dell'agire e dell'essere che scaturisce da quell'antropologia complessiva di cui si parlava prima, deriva l'indicazione di un'economia in cui i beni materiali siano prodotti e distribuiti in modo più equo. Contemporaneamente, siamo anche chiamati a fare un salto di qualità dai beni materiali ai beni immateriali, vale a dire i beni legati all'istruzione, alla formazione, alla conoscenza, alla cultura, i quali richiedono modalità produttive di tipo nuovo e possono comportare una fruizione che non sia di carattere escludente bensì includente (i beni immateriali sono "inclusivi" perché si sottraggono ai limiti quantitativi e addirittura esigono la partecipazione degli altri). Ci si apre, così, anche alla prospettiva dei beni relazionali, beni che possono essere usufruiti grazie alla relazione con gli altri. Indubbiamente diventa importante, a livello del costume e delle abitudini quotidiane, una diversa conduzione della risorsa temporale, ma è il caso di dire che non si faranno molti passi in questa direzione se non maturerà un'adeguata consapevolezza culturale a livello generale. In definitiva, in questa prospettiva viene proposto un vero e proprio passaggio di civiltà, che peraltro invita ad andare oltre la cultura della penuria o della scarsità, nella quale continuiamo ad attardarci perché pensiamo alla ricchezza come fatta esclusivamente di beni materiali e governata dall'esclusione piuttosto che dalla inclusione. Tale passaggio di civiltà non può non essere sostenuto dal progetto di un riequilibrio antropologico, con la ricomposizione delle dimensioni del lavorare, dell'agire e del contemplare di cui si diceva prima. Occorre correggere la sfasatura di una civiltà impostata, in modo unilaterale, sull'homo faber, sull'uomo della produzione e della manipolazione illimitata della realtà. Bisogna passare da atteggiamenti di sfruttamento e di manipolazione ad atteggiamenti di cura e di manutenzione del reale. E proprio da tutto ciò può anche scaturire un ampliamento delle possibilità di lavoro e di occupazione. Il discorso che ho fatto, per quanto sommario, pone infatti le premesse culturali di un ampliamento della sfera del lavoro, sia in termini di opportunità oggettive, sia in termini di partecipazione soggettiva. Si apre così il capitolo di nuovi lavori per bisogni antichi, che oggi sono solo parzialmente soddisfatti o mal soddisfatti, e di nuovi lavori per bisogni nuovi, lavori legati specialmente alle accresciute esigenze della persona. Non sono un sociologo del lavoro, ma se leggete l'interessante libro di Luciano Gallino, Se tre milioni vi sembran pochi (Einaudi), scoprirete come in questo volume si metta in evidenza l'esistenza di una sorta di miniera a cielo aperto del lavoro, che è tutta da sfruttare. Ci sono, infatti, enormi opportunità di lavoro che ancora non vengono prese in considerazione, e che si riferiscono alla risposta al dissesto idrogeologico, ai rimedi alle disfunzioni e ai ritardi del sistema giudiziario con l'incremento dell'organico e del personale addetto, alla creazione e alla conservazione delle infrastrutture e delle comunicazioni, ai beni culturali che con una congrua organizzazione di competenze sia umanistiche sia scientifiche sono davvero un potenziale di lavoro enorme, alla formazione permanente che può generare occupazione sia per i